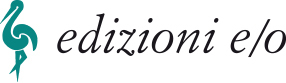Che tu mi veda o no io sono quella lì coi capelli neri e il naso prendi tre paghi uno. Quella lì che è già notte, ed è già fine, anche se tu volevi una storia in cui tutto è del suono giusto e del colore giusto, e le farfalle volano, e le persone parlano e amano e parlano e amano.
Tu te la puoi permettere una storia di quel tipo. [...] Sai che ti dico? Usala come straccio del bagno, quella storia, o che ne so, foderaci la gabbia del criceto. Insomma, basta che te la levi davanti, qui a Leeds non ti serve, e i ragazzini di Christopher Road te la ucciderebbero per strada.
Camelia vive con la madre a Leeds, una città "dove l'inverno è cominciato da così tanto tempo che nessuno è abbastanza vecchio da aver visto cosa c'era prima". Abitano in Christopher Road, "una via talmente brutta da essere una prova che Dio non esiste". C'è la neve, fa freddo ed è buio, a Christopher Road, dove "i fiori muoiono prima di sbocciare perché non c'è sole, e i feti hanno il vizio di strozzarsi con la placenta". A Christopher Road "non comincia mai niente. Semmai finisce. Finisce tutto, anche le cose che non sono mai cominciate".
Camelia ha un nome appariscente, il nome di un fiore orientale. Ma i fiori Camelia li recide, come fa con i vestiti che recupera nel cassonetto. Getta quelli nuovi, troppo puliti, fiammeggianti, luminosi per lei, e porta a casa gli scempi che un sarto incapace butta nel cassonetto vicino a casa sua. Abiti cuciti di sbieco, troppo stretti, con i bottoni sotto le ascelle, maniche sul sedere, pantaloni con tre gambe, scollature fino all'ombelico. Sbagli che nessun sarto avrebbe mai potuto fare, e per questo divini, di una bruttezza folgorante e perfetta, che Camelia sottopone a una ulteriore "chirurgia antiestetica", come forma di ribellione alla compattezza del mondo degli altri, come lo si percepisce quando si soffre. Una ribellione masochistica nei confronti di un mondo che l'ha pugnalata e da cui si sente esclusa, di cui la moda rappresenta il più immediato oggetto di condivisione dell'identità.
Camelia ha poco più di venti anni, ma per lei e sua madre il mondo si è inceppato tre anni fa, nel dicembre 2004, quando il padre è morto finendo con l'automobile in un fosso mentre era in compagnia dell'amante. Da allora sua madre si è chiusa in un mutismo assoluto, parla con la figlia nella lingua degli sguardi, si aggira per casa sporca e puzzolente come un animale, scattando ossessivamente fotografie ai buchi dei tavoli, delle tende, del formaggio, del soffitto.
Camelia ha lasciato l'università e i suoi studi di cinese e traduce manuali di istruzioni per lavatrici. È ossessionata dagli oblò, un buco come quelli che sua madre fotografa, un buco come quello in cui è morto suo padre. "Buco" in cinese ha la stessa chiave di "bambino".
Un giorno smette di parlare anche lei, si chiude in un rapporto morboso e fetale con la madre, fino a quando incontrerà Wen, il suo insegnante di cinese, che la farà ricominciare a parlare. Passando dall'anoressia alla bulimia verbale, le parole di Camelia sono suoni vomitati come cibo, che gli altri non capiscono ugualmente, perché le parole distruggono, non condividono, fraintendono, sono contrarie alla vita. E allora l'ideogramma, espressione visiva inequivocabile della lingua, è l'unica strada per ritrovare il senso perduto nel segno e far coincidere nuovamente significato e significante.
Camelia ama Wen, ma lui la respinge, angosciato da segreti inconfessabili, un fratello strano, una ex-fidanzata che non si sa che fine abbia fatto.
Per ognuno c'è un momento in cui uno sfrenato istinto di sopravvivenza si risveglia e si fa spazio nel mondo immobile della depressione. Anche la madre di Camelia conosce un uomo, ma quella casa cadente di Christopher Road proprio non sopporta la felicità e l'inverno torna senza via di scampo.
Settanta acrilico trenta lana è il romanzo di una esordiente catanese, Viola Di Grado, nella quale la e/o dimostra di credere davvero molto. Laureata in lingue orientali a Torino, Viola Di Grado ha fatto l'Erasmus a Leeds, poi ha viaggiato in Giappone e in Cina, e ora si sta specializzando in filosofia cinese a Londra. Questo romanzo lo ha finito di scrivere due anni fa, quando di anni ne aveva ventuno. Eppure Settanta acrilico trenta lana dimostra una originalità e maturità di lingua e contenuti davvero rara per una scrittrice della sua età. Definita "dark come Amélie Nothomb e letteraria come Elena Ferrante", Viola Di Grado costruisce il suo romanzo sulla lingua, attraverso iperboli, sinestesie, allitterazioni, parole che dipingono una natura al neon, di plastica, - acrilica, appunto -, sezionando lo spazio ovattato di questa Leeds letteraria come un bisturi. Una lingua che taglia e squarcia la pagina, come se fosse un fiore o vestito. Parole che coniugano esperienza corporea ed estetica, che si collocano esattamente sulla pagina come ideogrammi inscritti nel loro quadrato ideale. Parole che contraddicono la sterilità dell'esperienza depressiva, debordano fuori dal tracciato, si scompongono, si mescolano, si uniscono: chiavi di volta, parole che si fanno carne e riempono lo spazio, parole che significano sempre qualcosa di più della loro forma. Una lingua cesellata come una porcellana orientale eppure sfrontata e insolente come quella che solo a vent'anni si può avere.
Settanta acrilico trenta lana è il romanzo di una bellezza straziata, di una vita persa, ritrovata, persa di nuovo - ciclica come un buco -, di una vita che muore ogni giorno e ogni giorno risorge, per lanciare una provocazione alle nostre candide esistenze.
- Home
- Recensioni
- Settanta acrilico trenta lana di Viola Di Grado: una storia di alienazione urbana