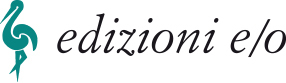Camelia vive a Leeds, in una strada anonima, dove l’inverno non sa finire, anche se i giorni sul calendario si succedono, il sole smuove il ghiaccio. Ha il nome di un fiore appariscente, originario dell’Asia, bianco, rosa, rosso acceso. Ma per lei i fiori non hanno diritto di voce: li recide, ne fa scempio, li calpesta con gli anfibi. Stessa cosa con i vestiti – getta quelli nuovi nel cassonetto da cui ne recupera altri, tutti sconvolti, con file di bottoni nel punti più impensabili o maniche in sovrannumero, interviene sui suoi propri come una novella Dr Frankenstein,
“Sulla sedia i vestiti storpi sembravano pelli di animali scuoiati.
Presi quello con le maniche diverse e in uno slancio di creatività sadica ne amputai una con le forbici. Poi dimezzai la gonna e ricucii la parte tagliata su un altro vestito, di sbieco, come una cintura di sicurezza. Continuai per ore con sfrenato godimento a squarciare pantaloni, mutilare tasche, scambiare bottoni, innestare brutti colletti su altri vestiti ancora più brutti. Finché la bruttezza si fece folgorante, perfetta, e non bastavano più i vestiti del cassonetto, dovevo fare trapianti di stoffe dai vestiti del mio armadio. Così diventavano ancora più brutti, soprattutto quando facevo incroci di laboratorio tra gli orsacchiotti dei pigiami e gli strass dei vestiti da sera, dio che eccitazione”.
Indossa i suoi abiti solo per percorrere un breve tratto di strada, dalla sua casa al videonoleggio, dove per un qualche misterioso accidente le consegnano sempre il film sbagliato dentro la custodia giusta. Ed ogni volta che la realtà la incrocia, ne scaturisce un grigio permanente, una foschia di neve, ma di quella neve sporca, straziata dai gas di scarico e da ruote motrici, che fa male allo sguardo. Nel romanzo di Viola Di Grado e nel mondo di Camelia tutto si è inceppato, dal giorno in cui il padre è morto insieme all’amante in un incidente d’auto. Livia, la madre, una flautista bella e algida, gira per la casa animalesca, usa lo sguardo per comunicare e fotografa ossessivamente buchi. O mancanze, voragini, precipizi. La ragazza ha rinunciato ad una vita propria, traduce dall’italiano in inglese manuali per lavatrici, istruzioni semplici su come introdurre fango e far uscire pulizia, che però non si applicano con altrettanta facilità alle persone. Ed anche lei cade nel mutismo, finché l’incontro e l’amore per Wen, suo insegnante di cinese, la farà ricominciare a parlare, vomitando i suoni come cibo, passando dall’anoressia alla bulimia, dal rifiuto del linguaggio all’ingorgo dei significati. Dal suono all’ideogramma, dalla parola svuotata ad un senso nuovo da trovare nel segno, nell’immagine, l’espressione visiva del sé e della lingua. Tuttavia anche Wen ha i suoi spettri: , un segreto che non riesce a confessare, un’ex- ragazza con un altro nome di fiore, Lily, morta o forse scomparsa, uno strano fratello che indossa magliette con frasi ridicole, imitazioni di slogan giovanili già di per sé vuoti. L’atteggiamento autopunitivo di Camelia, con il quale tenta un’impossibile espiazione delle colpe paterne e della morte, si rispecchia in tutti i personaggi, proseguendo verso una follia che è linguistica, prima che mentale. I vestiti, le parole soppresse, gli ideogrammi, il corpo tormentato, non sono infatti che linguaggio, l’unica arma per vivere, la più potente per ricrearsi anche in modo distorto, fino all’annullamento. Il linguaggio di Camelia e la scrittura dell’autrice, fatta di poesia, perché fatta di tagli, di asciuttezza, di trasformazioni improvvise degli oggetti più comuni, riadattano l’ambientazione urbana alla temperatura interiore, dove il freddo cristallizza e poi spacca in silenzio, come una moderna Bella Addormentata, il cui sonno invincibile genera rovi, o come un’Alice-Regina di Cuori, che nel paese del trauma non può essere compresa, parla con se stessa tentando di salvarsi nell’autoironia e taglia teste di papavero, pezzi di carne.
Proprio l’uso della lingua ci ricorda infine che un buon libro non è fatto solo della storia o delle storie che racconta, ma ne evoca altre, apre scatole riposte, fa intravedere ombre dietro le tende. In questo folgorante esordio narrativo sono fondamentali i dettagli, i richiami all’universo contemporaneo di mode, passioni e comportamenti, comuni a Viola e Camelia, come a tanti lettori e che proprio verso questi ultimi aprono brecce per l’immaginazione.
La libertà dell’ abbigliamento nelle città inglesi, dove in pieno febbraio è possibile sedersi su di un autobus tra ragazze in ballerine e piedi scalzi, vecchi hippie, signore cinquantenni con i capelli azzurri e guardaroba misti che non tengono conto del clima; i negozi vintage colmi di stranezze, il desiderio di vagare senza metà per paesaggi di periferia, fatti di takeaway e noleggio-video, di niente che sia bellezza e che pure sa parlarci; la stupefacente solitudine di inverni costanti, in cui il migliore amico è il personaggio che tiriamo fuori dai nostri stracci, dalle sequenze di un film in una lingua aliena, che ci addormenta e ci fa esplodere come la bomba in un video di Björk, che devasta un intero luogo affollato per svegliare una sola persona.
- Home
- Recensioni
- Settanta acrilico trenta lana. La crudeltà dei fiori