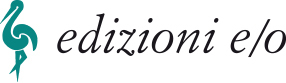All’indomani del terribile tsunami che l’11 marzo 2011 si abbatté sulla costa orientale della regione Tohōku, dei settantamila pini che separavano il mare dall’inizio delle attività umane, dell’ampia Distesa di Pini di Takata-Matsubara, ne rimase solo uno. Si trattava di un luogo colmo di magia, attrazione nazionale inclusa nella lista dei Cento Paesaggi del Giappone (日本百景), amatissimo da residenti e turisti.
Quel pino, miracolosamente sopravvissuto al disastro, divenne simbolo della speranza d’un popolo intero, di chi vi scorgeva la possibilità di un ‘dopo’ che desse risalto più a quanto restava che a quanto, di enorme, si era perso. Sul terreno azzerato dall’acqua, nel vuoto orizzontale di macerie e morte che era divenuta la costa, quel solo esemplare si stagliava in verticale con straziante bellezza.
L’albero della speranza, scritto da Arai Man, poliedrico artista e scrittore giapponese, e pubblicato in Italia da E/O per la traduzione di Costantino Pes, è denso di memoria. Scaturito da una partecipazione radiofonica dell’autore, cui a pochi mesi dal disastro venne domandato un messaggio di incoraggiamento per quanti si stavano adoperando per la rinascita delle zone colpite, questo libro è uscito in Giappone con il medesimo titolo (Kibō no ki) nel novembre 2011 ed è divenuto successivamente un libro illustrato accompagnato da un dvd (Tōkyō Hōrei, 2015), a dimostrazione dell’enorme successo ottenuto in patria, dove è stato inoltre fregiato di numerosi premi. Il tema, del resto, è caro ai giapponesi, tanto che solo un mese prima, nello stesso anno, uscì un altro volume illustrato di grande formato, sempre dedicato al pino superstite di Takata-Matsubara (Kiseki no ippon matsu, Takada Eri, Chōbunsha, 2011)
L’emozione cavalca le pagine scarne de L’albero della speranza, il linguaggio infantile del pino – nella finzione narrativa antropomorfizzato al femminile – veicola il racconto del mondo appena prima e subito dopo lo tsunami. La bambina-albero narrata da Arai Man, aveva in realtà 250 anni ed era alta 30 metri. Fu subito battezzata la “sopravvissuta”. Emerse tuttavia in un secondo momento che le sue radici stavano marcendo per via dell’acqua di mare che il terreno aveva assorbito durante lo tsunami, e nonostante gli immensi sforzi fatti per salvarlo – in quanto, appunto, esso era divenuto nel frattempo un simbolo di speranza -, l’albero morì. Quando si comprese che il processo non era reversibile, vennero «eseguiti degli innesti con rami prelevati dal pino», fu «tagliato e preservato con processi artificiali, per poi essere ricollocato sul sito nella forma e posizione originale», dando vita alla speranza di ricreare da quel solo esemplare, una nuova pineta.
Corredato dalle didascaliche fotografie di Kainuma Takeshi, cui sopra sono state trascritte alcune frasi pronunciate dalla bambina-albero, questo esile libretto è arricchito da una seconda parte che delinea il profilo del pino di Takata-Matsubara e una terza che, di queste pagine, narra la genesi radiofonica, gli intenti, stralci della biografia dell’autore.
La prima sezione pare la sceneggiatura di un libro per l’infanzia. I temi del resto ci sono tutti: il dramma della vita che si schianta, letteralmente, su una creatura, il sacrificio di chi ci ama, il rammarico d’esser vivi nonostante l’esistenza che si conduceva sia scomparsa, l’eredità gioiosa che si deve a chi ci ha salvato, la missione che ognuno di noi porta dentro di sé, soprattutto quando la Storia ci chiama al banco dei testimoni, e quel che ci è richiesto è innanzitutto il coraggio di andare avanti, da soli.
«Sì, questo ti chiediamo, vivi, vivi, continua a vivere per noi. La tua sopravvivenza sarà di conforto per me, anzi per tutta la nostra famiglia, e per ciascuno dei settantamila pini nostri compagni».
Circolava in quei giorni di lutto di ormai sette anni fa, la poesia dello scrittore Miyazawa Kenji, Ame ni makezu (“Non ci si arrende alla pioggia”) come un mantra atto a modulare il dolore di tutto il Giappone, – che dal gelido Hokkaidō si allunga fino alle estreme isole di Okinawa, dove l’inverno invece non esiste. In quei giorni in cui tutti davano il proprio contributo, e nessuno tentava di sottrarsi, persino le pubblicità in tv erano oscurate da messaggi di speranza, le marche più prestigiose vestivano a lutto gli spazi dedicati, celebrità si mostravano solo per dire cose esatte, sentite, intelligenti.
Non è la pura elegia del disastro a spingere avanti questa emozione, ma il fatto piuttosto che ogni generazione, in luoghi diversi del Giappone, e in diversa misura, ha esperito un terremoto o addirittura uno tsunami. Nel caso di Arai Man fu Niigata nel 1964:
«Ebbene, perché ho scritto questa poesia in prosa? Il motivo è semplice: anch’io sono una vittima del terremoto e dello tsunami. […] Per fortuna non riportai lesioni fisiche, ma rimasi comunque gravemente ferito nell’anima. Credo sia dovuto all’aver provato le paure di una vita intera in un solo giorno.»
L’albero della speranza ha il merito, oltre che di tenere accesa la memoria su un dramma, di spiegare del Giappone quella liricità semplice, talvolta fraintesa, quel pathos dolente, senza pelle, che solo una società controllatissima e disciplinata come quella giapponese sa produrre, per lo stesso principio per cui i manga mostrano un sesso conturbante e una violenza che lì, nel perimetro della pagina, resta fermamente circoscritto e sublimato.
L’approccio di questo libretto offre un interessante spaccato della cultura emotiva giapponese, del valore del kijō, 「気丈」, del “mostrarsi forte”, concetto secondo cui chi più soffre, meno lo dimostra. Si dice infatti che “più qualcuno si mostra forte, maggiore è la compassione che merita”. La tanto declamata compostezza del popolo del Sol Levante non va letta infatti come una diminuzione emotiva, bensì come una sua intensificazione nella mancata esternazione.
«Si tengono inoltre sotto osservazione i germogli nati dai semi delle pigne raccolte a Takata-Matsubara dagli abitanti del posto prima del disastro.» scrive Arai Man in conclusione della seconda parte del libro.
Ed è bello immaginare una colletta della memoria, di bambini che hanno sottratto le pigne per giocarci a casa, magari in giardino, come fanno tutti i piccoli in fondo, in qualunque parte del mondo, e si portano dietro il ricordo tattile di un momento gioioso, la magia di un pezzetto di natura in palmo di mano.
Come a dire che la memoria, o perlomeno il suo tentativo, sa placare lo strazio di chi resta e porre le basi per la speranza che naturalmente è destinata a prendere il posto del lutto.