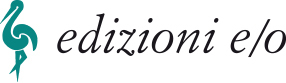Perché perdere tempo a inventarsi una trama quando il destino ti circonda di una madre di ottimi origini che, sette matrimoni alle spalle, in preda a una delle sue continue sbronze, spara contro il marito o dà fuoco alla casa, di un padre texano belloccio, metà cherokee e metà irlandese, operaio nell’industria petrolchimica, che intrattiene un bar di amici sfigati con mille racconti alcolici e, anche se portato a casa a spalla, riesce sempre a svegliarsi col sorriso sulle labbra e un caffellatte per le sue bambine? Perché un romanzo, se il fato ti mette accanto anche una sorella, Lecia, che a undici anni guida portando la sorellina con sé e riuscendo a convincere il poliziotto a non farle la multa sostenendo di aver dimenticato la patente a casa? No, niente fiction. Ce n’era abbastanza nella realtà. Quando Mary Karr, classe 1955, americana, decise di scrivere, era il 1995, la sua scelta fu chiara: un memoir, what else? E quando lo annunciò alla mamma e a Lecia, sapete cosa le rispose la genitrice? “Diavolo, sputa pure tutto quello che ti pesa sullo stomaco... Se me ne fosse mai fregato qualcosa di quel che pensano gli altri, avrei fatto biscotti e sarei entrata in qualche associazione genitori-insegnanti”. La sorella poi, lo sapeva, avrebbe appoggiato qualsiasi suo progetto; una volta le aveva addirittura detto: “Vuoi ammazzare dieci persone? Brava, ci sono un sacco di bastardi che non meritano altro”. Fu così che Mary Karr pubblicò Il club dei bugiardi (e negli anni seguenti gli altrettanto autobiografici Cherry e poi Lit: A Memoir). Il successo arrivò subito: un anno ai primi posti della classifica dei più venduti sul New York Times, quattrocento, cinquecento lettere a settimana (ancora oggi una sessantina all’anno). Quella famiglia disfunzionale sembrava spalancare le porte interiori della gente: una buona percentuale dei lettori che aveva vissuto esperienze forti (e difficili) nell’infanzia finalmente vedeva come si faceva a non rinchiudersi nella vergogna e si rivolgeva a lei per raccontare la propria improbabile saga famigliare, come la storia di quel bambino nella cui morbida tutina i genitori avevano nascosto dosi di eroina. Gran terapia raccontare. Meglio senza piangersi addosso, come fa Karr. Siamo tra il ’62 e il ’63, lei ha sette anni, la sorella dieci, anche se la scena si muove avanti e indietro. Loro vivono in una cittadina chiamata Leechfield, invasa dai fumi petrolchimici (Business Week secondo la Karr l’ha messa tra le più brutte del pianeta). Man mano che si delinea la famiglia Karr, appare chiaro che non si tratta solo di eccentrici ma di un difficile nucleo di spostati da cui le due ragazzine si difendono, tentando di proteggerli. Soprattutto dalle loro ubriachezze, violenze o perdite di sensi senza fine. Intorno, altri spezzoni di famiglia altrettanto pazzi, come lo zio paterno che non parla con la moglie da quarant’anni e ha diviso la casa in due con una sega elettrica. Tutto è stravagante, a partire dall’idea di cena: sedersi tutti sul lettone di mamma e papà guardando in direzioni diverse. Forse la più fuori di testa resta la madre, Charlie Marie: sognando gli anni Cinquanta in cui viveva nel Village, a New York, girava con un tomo del Capitale di Karl Marx (per il padre invece l’unico Marx era Groucho), a divorare Sartre e ad ascoltare opera e jazz raffinato. Accanto, una cassa di bottiglie di vodka. Anche il marito beve, sia chiaro. Tanto che nessuno dei due si accorge se il babysitter abusa della piccola figlia. Il tutto in una lingua perfetta che va dal poetico al lirico, al texano triviale. E con l’incredibile compassione sorridente con cui Mary Karr riesce a raccontarlo.
- Home
- Recensioni
- Sbronza di famiglia