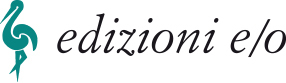Già, la Sicilia: in cui c’è un isolotto, l’Isola delle Femmine, ove qualche secolo fa, secondo una leggenda popolare, vissero prigioniere, per sette anni, tredici fanciulle turche, macchiatesi di chissà quali gravi colpe. La stessa terra che ha dato i natali a uno scrittore, Leonardo Sciascia, il quale, in un libro del 1986, La Strega e il capitano, si occupò d’una secentesca vicenda di stregoneria. In Sicilia vive, tra medesime suggestioni, Simona Lo Iacono, di professione magistrato con già tre libri alle spalle, il cui ultimo elegante romanzo, Le streghe di Lenzavacche, è ora in corsa per la cinquina del premio proprio allo Strega intitolato. Di che streghe stiamo parlando? D’una singolare comunità di donne perseguitate, tutte reiette ed emarginate, accusate di essere istigatrici del demonio, che nel Seicento, in patto di mutua solidarietà contro le offese del mondo, a Lenzavacche si rifugiarono. Ma anche di due loro remote discendenti, Tilde e sua figlia Rosalba, e cioè la madre del piccolo e sfortunato Felice (gli «zigomi montagnosi», la «testa ciondolante che i medici non riuscivano a raddrizzare»), avuto avventurosamente da un arrotino arrivato chissà come e perché, ma morto prestissimo e dolorosamente (il «santo», interessato, più che a se stesso, alla salute degli ultimi), le quali, nell’anno di grazia e fascistissimo 1938, in quel paese vivono. Una famiglia anomala e malguardata, che però gode della protezione del dongiovannesco farmacista Mussumeli. Decisivo, però, è l’arrivo in paese del maestro Alfredo Mancuso, un giovane di «poco più di ventitré anni», il quale «non indossa le camice nere del regime», «ha le unghie sporche di inchiostro e gli occhi stanchi delle veglie notturne»: uno che, insomma, ha l’aria d’un sognatore che ami molto, come Rosalba, i libri e che, appunto, «spenda la notte a inseguire le storie».
Occorrerà dire che il romanzo si divide in due parti e un epilogo. Nella prima si alternano le voci di Rosalba e di Alfredo, il quale si rivolge per lettera a una fantomatica zia, la cui inaspettata identità apprenderemo alla fine del romanzo. Scopriremo invece nella seconda parte, il testamento di Corrada Assennato, redatto «in Lenzavecche nell’anno di Dio 1699» in un fantasticato italiano secentesco, ove, di profezia in profezia (anzi «profeticheria»), ci si dipanerà quello che è il libro d’una restitutiva e appagata agnizione: alla faccia del fascismo e di ogni oscurantismo. Un libro il cui succo, se si vuole, si trova tutto qua, nelle finali parole di Alfredo: «Al che ho capito che ogni volta che una donna sarà madre a dispetto del mondo, e racconterà storie vincendo la morte, le streghe torneranno, cara zia, ancora e ancora, con tenacia e compassione». Nulla da eccepire, se non opporre diverso sentimento del mondo e degli uffici della letteratura: e soprattutto un’idea assai meno agiografica del raccontare storie, del loro beneficio in funzione d’una migliore qualità della vita. Differentemente da Simona Lo Iacono, purtroppo, non credo nel potere salvifico delle storie che, ormai, non fanno bene nemmeno più alla letteratura: sempre più illusiva e criticamente disarmata. Né nutro particolari speranze sulla capacità di riscattarsi e riscattarci di reietti e emarginati. Ma questo non è colpa da attribuire a questa scrittrice di incantesimi e malie, ma solo alla mia ipocondria.