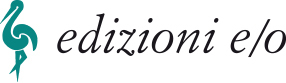Mi torna in mente “La strega e il capitano”, libro minore e poco noto di Leonardo Sciascia. Libro nel quale il grande scrittore siciliano ricostruisce la vicenda di una certa Caterina Medici, condannata per stregoneria, strangolata ed arsa in piazza il 4 marzo 1617. Caterina è solo una delle tante donne, nel corso dei secoli, ad essere stata accusata di avere poteri diabolici e letali; una delle tante donne che, come scrive Sciascia, “…credeva di essere una strega o, quanto meno, aveva fede nelle pratiche di stregoneria. E forse una fede meno intera di quella dei suoi accusatori: poiché, in fatto di stregoneria, l’inquisitore e l’inquisito, il carnefice e la vittima, partecipavano dell’uguale credenza…“. Poiché avversare la stregoneria implica, da parte di inquisitori, giudici e giustizieri di ogni genere, una fede in tali pratiche pari a quelle delle donne ritenute streghe. Altrimenti perché tanto impegno?
La Caterina di cui Sciascia ricostruisce la storia è vissuta e morta a Milano. Le streghe di Lenzavacche, invece, sono siciliane. Sempre e solo donne, chiaramente. Magari madri di figli senza padri, mogli ripudiate ed escluse, spose gravide ed emarginate. Donne che, sempre nel famoso ‘600, si riuniscono in una casa attorno alla figura di Corrada Assennato, ripudiata da un padre che aveva scacciato sua moglie e il figlio che aveva in grembo condannandoli alla morte e all’oblio. Corrada, raccolto l’anatema paterno, si ritira proprio lì dove sua madre e il fratello nato morto erano stati sepolti, a Lenzavacche. “Rivestivasi di poi di saio monacale, mendicando e accogliendo nella villa madri diseredate e senza futuro. In poco meno che duecento e triginda die la villa popola vasi di ingravidate, di moribonde e peccatrici, chi per violenza o abuso, chi per follia d’amore“. Davanti ad una comunità di donne tanto neglette e disprezzate, l’ignoranza e l’odio non tardano a farsi sentire. Alla diceria segue l’accusa di stregoneria ed all’accusa di stregoneria seguono la violenza e la morte.
Ma le streghe di Lenzavacche, come tutte le donne che conoscono gli angeli delle erbe, che sanno leggere e scrivere, che sono dotate delle stesse qualità di un uomo, hanno saputo sopravvivere e partorire figlie a cui tramandare insegnamenti e misteri, conoscenza e doni. Quegli stessi doni che, nel 1938, sa governare perfettamente Tilde, discendente di quelle streghe che, un tempo, abitavano nella casa in cui la donna vive assieme a sua figlia Rosalba. Donne senza uomini, ovviamente. Ma rese madri da semplici sposi dell’anima e del seme. Tilde con Rosalba. Rosalba con Felice. Un figlio maschio nato da un padre amato perdutamente e senza ragione, arrivato per caso a Lenzavacche per arrotare coltelli e poi cacciato. Felice nasce senza essere atteso, ma nasce. “La prima volta in cui ti vidi eri talmente imperfetto che pensai che nonna Tilde avesse ragione. Avrei dovuto mettere sotto la tua culla otto pugni di sale, bere acqua di pozzo e invocare le anime del purgatorio. Poi dire tre volte: «Maria Santissima abbi pietà di lui», affidarti alle mani del primo angelo in volo e assicurarti al collo una catena della buona morte. Non lo avevo fatto. D’altra parte eri un imprevisto, e con gli imprevisti non si allestiscono scongiuri e preparativi“.
Felice pare un nome offerto come ossimoro. Perché Felice, qui o in Sicilia, è tecnicamente un “infelice”. Un bambino malformato che il destino sembra condannare inevitabilmente alla disperazione e all’abbandono. Ma bisogna sempre fare i conti con una madre che vive di libri e con una nonna dotata di virtù speciali. E il destino, al cospetto del potere di due donne di tal fatta, può semplicemente ripiegare e cambiare verso. In un tempo, come quello dell’era fascista, in cui la perfezione di un corpo e la forza fisica sono eletti ad obblighi morali, oltre che risorse per il trionfo del Duce e della Patria, essere difettosi ed imperfetti come Felice non è semplice. Ma Rosalba, con l’ausilio di nonna Tilde e dell’impareggiabile estro del farmacista Mussumeli, sanno come permettere a Felice di comunicare e muoversi. Inventano per lui strumenti quasi magici che tra impalcature, sputi, ruote e gorgoglii, fanno nascere nel bambino un desiderio grande quanto la sua voglia di vivere: andare a scuola.
Una bellissima fiaba. E’ soprattutto questo “Le streghe di Lenzavacche”. Una fiaba che racconta di un piccolo principe sfortunato che ha comunque la fortuna di nascere per amore e vivere tra l’amore. Perché è sempre con la volontà e la passione di chi ama che si genera quella mutazione che conduce la differenza o l’imperfezione a divenire ricchezza e nuova forza. Un storia piena di bene ma anche di difficoltà. Una vicenda che si muove, in parallelo, tra tempi e figure diverse ma vicine. Simona Lo Iacono, che avevo già apprezzato molto qualche anno fa grazie ad “Effatà” (Cavallo di Ferro), torna a confermarsi come un’ottima narratrice. Il suo stile immediato, leggero ed acuto riesce qui a coniugare la leggenda della stregoneria al romanzo familiare, la storia del nostro Novecento alla favolistica, il diritto alla suggestioni di una terra che sembra ispirarla meravigliosamente. Divertente l’idea di restituire voce a Corrada attraverso l’invenzione di un testamento del 1699 redatto nella lingua del tempo. Ho amato molto le atmosfere magiche e lontane raccontante dalla Lo Iacono, così come ho amato le sue insolite metafore e gli accostamenti, a volte un po’ azzardati, di immagini e parole.