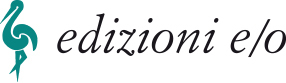A volte bastano poche parole, poche righe (certo, a volte non basta tutto il libro, ma non è questo il caso). Qui basta poco per farsi prendere. E siccome apprezzo molto la scrittura di Luca Poldelmengo -già autore di Nel posto sbagliato, pubblicato nella collana Sabot/Age (E/O)- non vedo l’ora che arrivi aprile!
Tutto questo per dirvi che l’incipit de I pregiudizi di Dio è davvero un ottimo inizio (e io ho abbondato nella trascrizione per aumentare la suspense).
Giudicate voi stessi.
§§§
Dicono che sono fumoso, contraddittorio, bugiardo. Sono tutti pronti a sputare sentenze su di me: poliziotti, magistrati, giornalisti, criminologi, conduttori televisivi, pure il primo stronzo che cammina per la strada. Perché questo non ce l’ha detto prima, come ha potuto fare quest’altro, non erano state queste le sue parole. Ma che ne sanno di come ci si sente di fronte a certe disgrazie? Provassero a fare un giro nelle mie scarpe prima di parlare. Vorrei vedere le loro, di vite, spiate come hanno fatto con la mia. Tutti bravi a fare i moralisti fin quando stanno dall’altra parte, ipocriti. E se lo facessero a te? Prova a pensarci. Se ti spogliassero e ti buttassero in piazza nudo, senza poter nascondere niente, ma proprio niente, sei sicuro che gli altri ti troverebbero così attraente? Sii sincero, non hai anche tu qualcosa di cui vergognarti, qualcosa che DEVE rimanere solo tua? Prima che succedesse questo schifo io avevo una vita meravigliosa, una villa in collina, un locale che era l’invidia di Tivoli, una Mercedes, due figli fantastici, una moglie che adoravo e che mi amava, e ora mi hanno portato via tutto. Tutto. Io l’ho capito che non gli piaccio a questa gente, ma non per questo non mi devono credere. E tu, almeno tu mi credi se ti dico che io sono la vittima?
Il sole di quella mattina di maggio doveva ancora raggiungere il fondo della valle. La brina ricopriva l’erba, inumidiva i rami secchi, bagnava la carne. Il cadavere era prono, disteso in un fosso, coperto da frasche gettate sopra per confonderlo alla vista. Il commissario Andrea Valente scese ancora di due passi. Arrivò di fianco a uno degli agenti in tuta bianca che stava liberando il corpo dai rami. Da lì poteva osservare con più chiarezza la figura femminile: la gonna di jeans sollevata, gli slip celesti abbassati alle caviglie, gli evidenti segni di escoriazione profonda intorno all’ano. Lungo il collo c’erano delle larghe ecchimosi, una guancia era poggiata sull’erba. Il viso violaceo era comunque riconoscibile. Il commissario Valente, un decennio in forza alla squadra mobile, sezione omicidi, non sarebbe stato in grado di ricordare quante volte aveva dovuto assistere a scene come quella. L’abitudine è una patina in grado di rivestire anche le esperienze più estreme, relegandole nel novero della normalità. Era questo tratto dell’adattabilità umana a rendere esercitabili professioni come la sua. Ma questa volta era diverso, il diaframma che separava l’uomo dal poliziotto era venuto meno. Andrea aveva lasciato due passi indietro il commissario Valente, era uscito allo scoperto, ed era stato investito dall’angoscia.