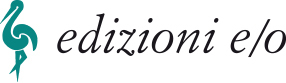Baghdad, inverno 2005, Saddam è caduto, l’occupazione americana si trascina da un paio d’anni, la guerra civile a colpi di autobomba e kamikaze fa registrare ogni giorno nuove stragi. Lo straccivendolo Hadi Al-Attag che ha più familiarità con la bottiglia che con i suoi simili, si aggira per le strade di una città resa spettrale dal conflitto per portare a termine il compito sinistro che si è dato: raccoglie e cuce tra loro resti umani perché è convinto che attraverso questo nuovo corpo potrà restiture la dignità alle vittime del terrore. Ma accadrà qualcosa che neppure lui poteva aspettarsi. Un’anima vagante, in attesa di sepoltura, prenderà possesso di quegli arti inanimati per dargli vita. La «creatura» ridestata dal mondo dei morti inizierà così a vendicare quanti sono stati assassinati, trasformandosi in giustiziere agli occhi di una popolazione disperata e alla ricerca di un qualunque conforto. Nel suo corpo Hadi ha riunito però sia le vittime che i carnefici, vale a dire anche ciò che restava degli autori di attentati suicidi e di killer caduti mentre eseguivano le loro missioni di distruzione. Quell’essere ha perciò bisogno di sangue innocente per continuare a vivere: da idolo degli abitanti dei quartieri popolari si trasformerà in breve tempo in un assassino sanguinario, le cui azioni efferate trasformeranno la vita quotidiana della città in un inferno ancor più orribile.
Ispirandosi alla celebre opera di Mary Shelley, lo scrittore e giornalista iracheno Ahmed Saadawi ha raccontato la tragica realtà del suo paese in Frankenstein a Baghdad, Edizioni e/o (pp. 352, euro 18), un romanzo che affronta con grande forza, ma sapendo alternare l’ironia e il gusto del paradosso al dramma e al racconto dell’orrore quotidiano della guerra, il destino di un popolo e di una terra.
Una creatura che è il prodotto delle stragi quotidiane, nel cui corpo convivono vittime e carnefici, che da eroe si trasforma in assassino: nel suo Frankestein convergono i drammi della recente storia irachena, da Saddam all’occupazione americana, fino al terrorismo fondamentalista. È così?
Il mostro è un’incarnazione della nostra società. O meglio, di tutte le contraddizioni che vi albergano. Nella versione originale il suo nome corrisponde alla parola Shisma, che in arabo significa «come si chiama», una scelta con cui volevo sottolineare l’ambivalenza degli iracheni di fronte alle violenze, in particolare a quelle interconfessionali. Per questo in lui coabitano le vittime e gli assassini. Rappresenta il prodotto delle nostre paure, dei nostri pregiudizi e della nostra ipocrisia. È il simbolo di quel desiderio di vendetta presente in ciascuno di noi che alimenta una violenza senza fine.
Quando un iracheno uccide un altro iracheno non è mai solo a premere il grilletto. Ha dietro di sé decine di altre persone che partecipano simbolicamente a quell’atto: coloro che incitano all’odio, quelli che chiedono vendetta. È di questi assassini invisibili che parla soprattutto il mio romanzo.
Un critico di «Asharq Al-Awsat», l’influente quotidiano arabo pubblicato a Londra, ha paragonato il suo libro a «Crash» di James Ballard, tracciando un’analogia tra la creatura di Baghdad e lo scienziato-teppista Vaughan, che si aggira come un «angelo ossessivo» per le supertrade e sostenendo come in entrambi i romanzi è inutile cercarvi traccia del bene e del male.…
È davvero difficile giudicare lucidamente quanto sta avvenendo nel mio paese e, in ogni caso, mi sarebbe impossibile indicare una parte coinvolta nel conflitto, o meglio nei conflitti che vi sono in corso, che abbia più ragioni o torti delle altre. Ciò non significa che ogni iracheno sia una vittima innocente o un criminale assassino: ciascuno è in parte vittima e in parte carnefice. Tutti sono a vario titolo responsabili di quanto è accaduto e continua a succedere e, per questa via, nessuno può davvero considerarsi innocente. In questo contesto, posso solo dire che i soli «eroi» di Baghdad sono le persone che cercano di condurre una vita dignitosa malgrado l’inferno che li circonda.
Alcuni dei protagonisti vivono nel vecchio quartiere popolare di Bataween, dove hanno convissuto a lungo sciiti e sunniti, ebrei e cristiani, immigrati egiziani e sudanesi. Cosa è rimasto di tutto ciò?
Baghdad ha una storia millenaria dietro di sé, è stata una delle culle della civiltà mediorientale e una capitale imperiale. Per secoli qui hanno vissuto pacificamente persone di religione e tradizioni diverse. Solo nel corso dell’ultimo decennio tutto ciò si è trasformato in una sorta di benzina per la guerra civile strisciante ancora in corso: oggi ogni alterità è percepita come una minaccia e ogni diversità come un nemico da abbattere. Perciò di quel passato resta sempre di meno, anche se la città non ha perso del tutto questo suo profilo, malgrado le stragi e gli omicidi quotidiani. Resta semmai celato, nascosto dietro le mura di casa.
Pur non rinunciando a tratti anche all’umorismo, questo romanzo si misura soprattutto con l’orrore che pervade la vita degli iracheni. In questo senso, come giudica la «narrativa» della morte messa in scena dalla propaganda dell’Isis?
Quello che fanno con i loro video è all’opposto di quello che cerco di fare io con la scrittura. Scrivendo si continua a sognare ad occhi aperti e questo quale che sia la situazione che si ha intorno. Gran parte degli eventi descritti nel libro, attentati, stragi, omicidi efferati, sono ispirati a fatti di cronaca realmente accaduti. Mentre scrivevo non c’è mai stato nessun compiacimento nel rielaborare ciò che vedevo in chiave letteraria. Al contrario, descrivere l’orrore quotidiano di Baghdad rappresenta un possibile antidoto alla violenza, un modo per cercare di cambiare le cose. Restare passivi, essere dei semplici spettatori equivale ad un tacito incoraggiamento alla violenza. Ed è questo ciò che vuole l’Isis.
Lei cita spesso Ernest Hemingway e Gabriel García Márquez come fonte di ispirazione, quanto c’è di queste sue passioni letterarie in «Frankestein a Baghdad»?
Cerco di ispirarmi a questi autori perché sono stati anch’essi giornalisti prima di diventare scrittori. Credo che la narrativa sia più adatta del giornalismo per esprimere l’esperienza emotiva di vivere in una città in cui l’orrore è diventato la norma. Di Hemingway ammiro soprattutto la prosa essenziale ed austera che continua ad avere una grande influenza nella letteratura araba contemporanea. Quanto a Márquez, si direbbe che in molti aspetti del suo lavoro si respiri qualcosa di orientale, come nel modo fantastico scelto per descrivere l’America Latina. Soprattutto è stato uno dei maestri del romanzo postmoderno e il mio libro è stato presentato da più di un recensore proprio come un efficace romanzo arabo postmoderno: molti hanno scritto che ho fatto ricorso al realismo magico per mescolare la fiction alla realtà di morte della mia città.
Per scrivere il romanzo si è trasferito per lunghi periodi nella zona del Kurdistan iracheno, «per cercare maggiore tranquillità lontano dalle bombe di Baghdad». Cosa significa essere scrittori nell’Irak di oggi?
Ho scelto di continuare a vivere a Baghdad malgrado la guerra perché qui c’è tutta la mia vita. Non è facile, devo ammetterlo: l’anno scorso un kamikaze si è fatto esplodere in uno dei caffé che sono solito frequentare solo un’ora dopo che ero uscito e ha ucciso molti miei amici. Ma non ci sono solo i pericoli e la paura. Credo che cercare di scrivere in una simile realtà rappresenti anche una sorta di privilegio. Sento la responsabilità di essere un osservatore imparziale di quanto sta succedendo, ho infatti la possibilità di raccontare ciò che vedo e di esprimere la mia opinione al riguardo e chi legge i miei libri, i articoli o segue quello che pubblico sui social network, sembra dare molto peso a quanto dico. Anche per questo non ho alcuna intenzione di andarmene, anche se vivo un conflitto interiore, tra il mio bisogno di scrivere e la paura della morte che non mi abbandona mai.
Dalle sue parole si sarebbe portati a pensare che la vita culturale di Baghdad sia sopravvissuta a quindici anni di guerra.
Potrebbe sembrare un paradosso, ma è così. La scena culturale è ancora molto vivace. Non parlo solo della letteratura, ma anche della musica, dell’arte e del teatro. Malgrado la guerra, o forse proprio a causa di essa, c’è una gran voglia di fare tante cose. Le faccio un esempio: c’è un mio amico violinista che insieme ad altri musicisti organizza concerti improvvisati nei luoghi in cui ci sono stati degli attentati: combattono la morte attraverso la musica che per loro è vita. Scrittori e autori di tutto il paese arrivano a Baghdad perché sanno che qui è ancora possibile trovare un editore o mettere su una pièce. E non si tratta di un fenomeno che riguarda soltanto un’élite. Nel centro della città c’è ancora la «via dei libri», la Mutanabbi Street, una strada lunghissima che ospita su ciascun lato librerie e bancarelle di libri, dove si può trovare tutto ciò che viene pubblicato nel mondo arabo. Ed è una strada sempre affollata, malgrado le bombe.
Il suo alter-ego nel romanzo, Mahmoud il giornalista, afferma che «tutte le tragedie che stiamo attraversando sono riconducibili ad un’unica causa: la paura». Pensa che l’Irak potrà vincerla?
Quando ho terminato il libro, oltre tre anni fa, le cose sembravano sul punto di migliorare. Poi è entrata in scena l’Isis, la guerra si è estesa anche alla Siria, è cresciuta l’influenza negativa dell’Iran e dell’Arabia Saudita e non solo la situazione irachena, ma quella dell’intero Medioriente non ha fatto che precipitare. Malgrado cerchi di conservare l’ottimismo, devo ammettere che la situazione è peggiorata e che invece di vincere l’orrore e la paura ne siamo ancora di più prigionieri e non so dire davvero quando tutto questo potrà finire. Oggi, gli iracheni non guardano ad un futuro lontano: possiamo parlare solo di giorni e mesi, non di periodi più lunghi.
SCAFFALI
GIORNALISTA IN PRIMA LINEA E AUTORE DI FUMETTI. LA RESISTENZA A STRISCE NELLA CAPITALE IRACHENA
24clt1piccola Primo iracheno ad aggiudicarsi il prestigioso «International Prize for Arabic Fiction», il più importante riconoscimento per la letteratura del mondo arabo, che gli è stato attribuito lo scorso anno ad Abu Dhabi per il romanzo «Frankenstein a Baghdad», Edizioni e/o (pp. 352, euro 18,00), traduzione di Barbara Teresi, Ahmed Saadawi è nato nel 1973 nel quartiere a maggioranza sciita di Sadr City, nella periferia di Baghdad. Di formazione laica, figlio di un piccolo funzionario comunale, Saadawi ha lavorato a lungo come giornalista, per testate e tv locali e per il canale arabo della Bbc — per il quale ha coperto gli anni più duri della guerra civile tra il 2006 e il 2008 -, prima di dedicarsi completamente alla poesia, alla scrittura e al lavoro nel mondo dei comics: un suo fumetto è stato pubblicato nel 1999 sulla rivista egiziana «Akhbarak». Autore di altri due romanzi e di una raccolta di poesie, nel 2010 è entrato a far parte del progetto Beirut39 che riuniva i maggiori talenti della narrativa araba under 40. Sposato e padre di quattro figli, ha spiegato di aver utilizzato gran parte dei 50 mila dollari ottenuti con l’«Arabic Booker», insieme alla traduzione del suo libro in lingua inglese da parte di una casa editrice libanese, per pagare i debiti e sistemare i conti della sua famiglia.