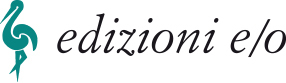“Il genocidio è stato preparato scientemente: nessuno in Ruanda si è meravigliato, né le vittime, né gli assassini. Alcune autorità erano a conoscenza del progetto… I machete distribuiti alla popolazione, gli incoraggiamenti, le incitazioni… Il messaggio era chiarissimo: uccidere i tutsi era una necessità. Anzi, un dovere. In quello sterminio, io ho perso quasi tutti i miei familiari: mio marito Innocent, i miei genitori, mia sorella Stéohanie, nipoti,zii… In tutto, sono morti 274 familiari miei e di mio marito, solo fra i parenti diretti. Sono riuscita a salvare me e le mie tre figlie: Anna, Amelia, Amanda. Ho tenuto duro per loro”.
Siamo a Roma, in un bel palazzo del centro storico, sede del Centro culturale dell’Ambasciata di Francia. Lo sguardo di Esther Mujawayo, sociologa e psicoterapeuta, originaria della città ruandese di Kigali, è a tratti allegro. Ma i suoi occhi diventano cupi ed immobili quando racconta quanto avvenne tredici anni fa, fra la primavera e l’estate del 1994, quando nel suo Paese, il Ruanda, ebbe luogo un sanguinario genocidio: un massacro con pochi paragoni nella Storia, fra le 800mila e il milione di vittime. Da quella strage, lei si salvò a fatica, riparando prima in un istituto di suore, poi nell’hotel Mille Collines (quello del film Hotel Ruanda), quindi in Uganda e infine in Germania, dove vive e opera tuttora come psicoterapeuta.
Un lavoro che le ha dato la forza di iniziare a “curare” le ferite, come racconta in due libri-testimonianza, scritti insieme alla giornalista franco-algerina Souâd Belhaddad: Survivantes e La fleur de Stéphanie. Quest’ultimo è appena stato tradotto e pubblicato in Italia, col medesimo titolo, per le Edizioni E/O.
Quali ricordi ha di quei momenti?
“Terribili, come racconto nel mio libro: la follia di una parte del Paese, l’odio che montava e montava, anche attraverso le radio, con lo scopo di realizzare la “soluzione finale”: lo sterminio dei tutsi. Per giunta, l’Occidente si voltò dall’altra parte: l’Europa non fece nulla. L’Onu era lì e non fece nulla. Forse – e me lo lasci dire – non valevamo abbastanza”.
C’erano anche hutu che non volevano quella follia. È così?
“C’erano. Io ricordo la storia della mia vicina di casa, che ci aveva salvato due volte in passato. Bisogna demistificare questa storia dell’odio tribale: in molti casi, hutu e tutsi vivevano e vivono fianco a fianco, lavorano accanto e frequentano scuole uguali”.
E allora dove stanno, a suo parere, le colpe principali?
“Il problema è quando la politica decide di strumentalizzare qualcosa o qualcuno, per propri fini. Allora basta poco per aizzare la massa: dopo l’indipendenza del nostro Paese, quel qualcuno da demonizzare divennero i tutsi. “Rubano il vostro lavoro”, “sono pericolosi”, “sono stranieri”, ci dicevano. Poi le discriminazioni, come ad esempio il limite negli accessi scolastici. E infine i massacri. Ma questo può accadere, ed è accaduto, pure in altre società: con gli ebrei nella Germania nazista, ad esempio. O nei Balcani, con procedure simili”.
Ora è in atto un faticoso tentativo di “riconciliazione nazionale”. A suo parere, con quali esiti?
“Ragionare in termini teorici di “riconciliazione nazionale” è difficile. Tuttavia, di nuovo, i miei connazionali affrontano una nuova convivenza, fianco a fianco. Abitano accanto persone che hanno ucciso, armate di machete, e familiari di coloro che sono stati uccisi. Dunque è necessario parlare di riconciliazione. Ma questo deve avvenire in un contesto di giustizia. Quando i sopravvissuti sono ritornati, non hanno trovato più nulla, neppure le case. Perciò, che si parli di riconciliazione, bisogna anche garantire loro un’abitazione, nutrimento per le famiglie e cure per le donne violentate dai carnefici e ora malate di Aids. In più, c’è un aspetto tremendo: ti può capitare di incontrare colui che ha massacrato la tua famiglia”.
Lei stessa ha vissuto l’esperienza dei Gacaca, i tribunali popolari in cui assassini e vittime vengono messi a confronto…
“Sì. Mi sono seduta su una panca di fronte a Etienne, l’uomo che massacrò mia sorella. Lui ha negato, nonostante le prove e le testimonianze schiaccianti. Io mi sono alterata. E il giudice mi ha chiesto di rimettermi a sedere e di moderare il tono. Ecco, il Ruanda è anche questo…”.