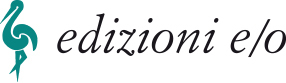La morte come altro da sé. Un’entità esterna che, dopo aver spento le funzioni vitali, si impossessa del corpo e inizia a demolirlo, chiamando a raccolta eserciti di mosche, larve, vermi, blatte, enzimi, gas, reagenti chimici. Un “lavoro” lungo e meticoloso, cui il morto può solo assistere da spettatore, coricandosi ogni sera accanto al suo inerte involucro per accompagnarlo nel disfacimento, con la nostalgia per tutto quello che mani, cuore e mente non sono più in grado di fare privati dell’energia di un cuore pulsante, ma con la drammatica consapevolezza di dover “vivere”, senza più il limite dell’estrema soglia da varcare, la dimensione ineluttabile dell’eternità.
Leggere questo libro di Viola Di Grado, caso letterario del 2011 con il suo Settanta acrilico trenta lana (Premio Campiello opera prima quell’anno), è un’esperienza per palati forti. Ma non tanto per l’effetto, indubbiamente urtante, delle molte pagine che sembrano estratte da un trattato di medicina legale, quanto per l’inquietudine che il suo singolarissimo approccio al tema della vita dopo la morte (o della morte dopo la vita) insinua nel lettore.
Dorotea Giglio, la protagonista, è una 25enne siciliana figlia di madre depressa e nipote di nonna depressa, la cui zia si è tolta la vita a soli 21 anni riempiendosi le tasche di sassi durante una nuotata al fiume. E che in una torrida giornata di luglio si taglia le vene nella vasca da bagno, sperando così di spegnere, col pulsare del sangue, il dolore sordo che i suoi pur giovani anni le hanno portato in dote. Un gesto estremo, pensato come liberatorio, e che invece prelude a un’altra non meno infelice dimensione di sofferenza, questa volta senza più nemmeno la speranza di potervi porre fine: la sofferenza di dover scontare - verrebbe da dire parafrasando Ungaretti - la vita da morti. Già perché i morti, nel romanzo della Di Grado, continuano a popolare il mondo dei vivi e a provarne, se non le sensazioni, il desiderio e la nostalgia delle stesse. Sono morti che soffrono di non poter invecchiare, che accompagnano i propri cari nel loro quotidiano, dormono nello stesso letto, mangiano alla stessa tavola, si lavano addirittura nello stesso lavandino. E che amano e provano a fare l’amore nel ricordo di quanto facevano da vivi. «Il desiderio – racconta Dorotea – è la cosa che mi manca di più di quando ero viva. Ma non posso dire di desiderarlo: per desiderare mi manca il corpo, la pelle, e il mistero del sangue che porta il calore. Ho solo uno sguardo spoglio, liberato dal mio teschio come un canarino in gabbia».
Tutto ciò è raccontato con una lingua asciutta e scabra, che procede per aforismi, secca e dura come solo gli autori siciliani sanno essere. Una lingua a tratti cruda e inclemente ma con soprassalti di comicità a comporre un pastiche nel segno dell’assurdo e del surreale, che riporta alla mente gli scenari macabri e grotteschi dei film di Tim Burton. Come nella scena in cui Dorotea racconta la sua “prima volta” all’obitorio, dove i morti spiegano ai “nuovi” morti «come gestire l’eternità». «L’obitorio è una sala parto; io e Anna ci divertiamo ad accudire i corpi gestanti, in dolce attesa dell’eternità. Hanno tanta paura e non capiscono cosa stia succedendo. Li vediamo arrivare come bambole dure, fredde, bianche. Come Pinocchio che torna burattino perché da umano soffriva troppo. Si vede sempre un’apnea nei loro occhi. Sotto i neon c’è una fragile anima che spinge per uscire da ogni corpo freddo. È difficile per tutte loro trovare l’uscita, ed è difficile riuscire a lasciare il corpo. È per questo che siamo lì, per aiutarle a uscire».
- Home
- Recensioni
- Viola Di Grado: la vita si sconta (anche) da morti