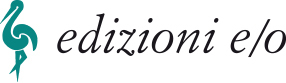Viola Di Grado si è fatta conoscere con un romanzo d’esordio intitolato Settanta Acrilico Trenta Lana (Edizioni e/o, 2011): un titolo che l’avrebbe facilmente collocata sullo scaffale dei romanzi rosa, tra I Love Shopping e le Sfumature.
Invece, nonostante i suoi (allora) ventitré anni e il look definito “oriental punk”, Viola ha vinto il Campiello Opera Prima 2011 ed è riuscita nella difficile impresa di far parlare di sé come di una scrittrice.
Dopotutto, che Viola Di Grado sappia scrivere, non è un segreto. Il suo potenziale emerge con una sicurezza adulta e un po’ sfacciata già dall’incipit del suo primo romanzo:
Un giorno era ancora dicembre. Specialmente a Leeds, dove l’inverno è cominciato da così tanto tempo che nessuno è abbastanza vecchio da aver visto cosa c’era prima.
Forte del precedente successo, Viola Di Grado ha deciso di affrontare il temuto esame della seconda pubblicazione rinunciando all’ironia nera che illuminava a sorpresa le pagine di Settanta Acrilico e narrando, ancora una volta in prima persona, la storia di Dorotea e del suo suicidio. Di quello che è accaduto prima e (sorpresa, ma non poi tanto) di quello che è accaduto dopo.
La sequenza alternata dei capitoli, che descrivono il tempo senza seguirne il corso, è un espediente semplice quanto riuscito. Le descrizioni esatte e quasi scientifiche della decomposizione del corpo di Dorotea ricordano la cruda narrativa americana alla Palahniuk (più che le poesie di Sylvia Plath come suggerito dalla critica), ma si fondono a fatica con la narrazione degli eventi.
In Cuore Cavo la storia passa in secondo piano, destinata a un ruolo secondario: a fare da impalcatura all’emozione e allo stile efficace, ma a tratti verboso e insistente, che non permette al lettore di dimenticare nemmeno per un istante l’età dell’autrice.
Quello che manca a Cuore Cavo è un climax che non arriva. L’assenza di una struttura narrativa forte rischia, come ogni volta, di trasformare il romanzo in un esercizio stilistico privo di umiltà e, come ogni volta, fa sorgere il dubbio che saper raccontare non sia sufficiente, che ci sia sempre più bisogno di storie. Perché c’è sempre più bisogno di storie.
- Home
- Recensioni
- Cuore cavo di Viola Di Grado