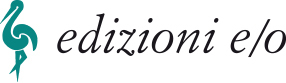Qualche giovincello che osa, azzarda e sperimenta - per fortuna - c'è ancora. Viola Di Grado - Settanta acrilico trenta lana, ricordate? - gioca alla grande scrittrice e a soli 25 anni lambisce già le caviglie dei Landolfi, dei Buzzati, dei Wilcock, con in più l'apertura d'orizzonte del linguaggio virtuale della globalizzazione. Qui tenta l'azzardo dell'aldilà, tra ironia e mestizia - senza sbavature new age, per fortuna - ma quello che poteva somigliare a un Amabili resti all'amatriciana diventa il racconto commosso di un addio violento con pentimento tardivo, un dialogo tra vivi e morti in cui gli sbandamenti degli uni si intersecano con le ragioni postume degli altri, ma senza forzature o effetti speciali spiazzanti.
Sembra tutto credibile, atroce a tratti, il percorso di recupero familiare tentato dalla venticinquenne catanese Dorotea Giglio, suicida nel 2011, per delusione d'amore forse, o per solitudine estrema. Dorotea non c'è più, ma esiste in forma di ectoplasma che soffia aliti di speranza e di riscatto sulla madre sola e stordita, sugli affetti più cari, mentre il suo corpo attraversa tutte le fasi crude e realistiche dello sfacelo post-mortem, fino alla consunzione totale. Nel rapporto mai violato tra gli eccessi di una ex vive e i viventi per caso che l'hanno conosciuta, Dorotea raggiunge una sua grottesca forma di maturazione "spirituale" in cui forse basta l'ombra dell'amore per riportare a galla le memorie più remote, per ritrovare la zia mai conosciuta e così simile a lei e ricondurre tutto in una quieta consapevolezza d'addio con i fiori che la madre lascia infine sulla tomba della figlia perduta, in un simbolico gesto di pace, per ricominciare.
- Home
- Recensioni
- Un gesto di pace alla figlia perduta