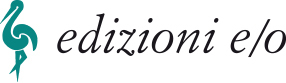A ventitrè anni, con Settanta acrilico trenta lana - premi Campiello e Rapallo opera prima 2011 -, Viola di Grado si è conquistata un posto tra le voci più interessanti della narrativa italiana. È stata tradotta in 8 lingue ed è tutt'ora in classifica negli Usa tra i libri stranieri più venduti.
Siciliana ma con una maschera dark che sa di saghe del nord, in cui lunghi capelli biondi fanno cornice a labbra tinte di nero su abiti vintage, completa la sua carta di identità originale con gli studi di lingue e filosofie dell'Asia centrale a Londra. E di quest'immaginario aveva impregnato il primo libro. A due anni di distanza, nel nuovo romanzo Cuore cavo (E/O, 176 pagine, 16 euro), in libreria da pochi giorni, racconta una storia di vita vivissima dopo la morte: quella di Dorotea Giglio, la protagonista.
L'incipit è un dissanguamento dal cuore al paesaggio di una Sicilia indifferente. Eppure da questa nuova dimensione postuma pare guardare al mondo con lucidità. Privata dei sensi, diventa sensibilità pura.
È stato difficile scrivere il secondo libro dopo il grande successo del primo?
Quello che è difficile per me è passare il mio esame: sono estremamente severa con me stessa. Dopo il primo ne ho scritti altri tre, Cuore cavo compreso. Ma solo con Cuore cavo ho sentito di aver dato il massimo, quindi è l'unico che ho voluto far leggere. Ogni romanzo per me è questione di vita o di morte, il mio perfezionismo non cede a compromessi.
Lì si partiva da un "buco", qui da un'inondazione di morte: come nasce per te l'ispirazione prima di una storia?
L'idea di questo romanzo mi è venuta su un aereo partito da Londra, mentre guardavo il cielo. Poi a un certo punto c'è sempre il momento del sogno: come il sogno sciamanico, che suggerisce allo sciamano che l'addestramento è terminato e che lui è finalmente pronto alla comunicazione con l'inumano, io faccio un sogno che accende delle frecce luminose nel mio inconscio. Lo sciamano incontra in sogno dei demoni che lo squartano e riconosce in loro i suoi amici, io sogno una ragazza che in modo più o meno violento vuole entrare nel mio immaginario e riconosco in lei il mio personaggio. Stavolta ho sognato una bambina molto magra e coperta di terra che mi guardava da dietro la porta a vetri di casa mia. Ero indecisa se farla entrare, ma una strega mi diceva “no, non farla entrare, lei ruba le vite degli altri. In realtà non importa se la fai entrare o no, lei non ha bisogno delle porte”. Poi la bambina entrava e rubava tutti i miei oggetti. Ecco cosa è successo: Dorotea Giglio è entrata dentro di me, rubando i miei strumenti emotivi e intellettivi per dare forma alla sua storia, e come uno sciamano (ecco cos'è lo scrittore) io l'ho fatta parlare attraverso di me.
Hai sempre chiarito l'estraneità da ogni autobiografismo, da cui l'allontanamento anche geografico e dell'immaginario. Dorotea però ci riporta in Sicilia, ha la tua età...
Trovo necessario ambientare le storie nelle città che conosco. Ho vissuto in sei città. Qui avevo bisogno di un luogo violento ma ordinario, un luogo che non si imponesse sulla storia come invece fa Leeds - che è un vero e proprio personaggio- in Settanta acrilico trenta lana: doveva restare un sottofondo, un palco. Riguardo all'età: ha un anno più di me, perché è nata nel 1986, e io ho scritto il romanzo quando ne avevo 24. Avrei anche potuto farla di 27 o di 33, ma perché dovrei? Tanto vale avvicinarla a me, così posso proteggerla meglio.
Lo schema familiare è costante: figlia, madre, incomunicabilità, e una grande assenza: il padre. C'è una ragione per l'insistenza sulla medesima origine del dolore?
Non è una ragione autobiografica: con i miei c'è un bellissimo rapporto, e con mia madre da sempre una grande complicità, non solo perché entrambe scriviamo e ci confrontiamo costantemente su quello che scriviamo. L'incomunicabilità è un tema che m'interessa moltissimo. In Settanta acrilico trenta lana è espressa nell'assenza delle parole: Camelia le vomita, madre e figlia parlano con un linguaggio fatto di sguardi. In Cuore cavo le parole di Dorotea, che è morta, non vengono sentite dalla madre. Lì la malattia era l' “anoressia verbale”, qui il “linguaggio non corrisposto” (“Io che mi preoccupavo tanto dell'amore non corrisposto, mi ritrovavo improvvisamente in una tragedia di linguaggio non corrisposto”, dice). Dorotea parla ma non viene sentita, scrive un diario (annotando la sua “interiorità” in senso letterale: il corpo che si apre e si decompone, sottoterra) ma non sa più leggere: può creare, ma la creazione non ha la risposta dell'interpretazione. Questo sfasamento riflette anche la mia intenzione di scrittrice: guardare le parole da lontano, come Dorotea guarda il mondo, distante, senza cadere in quelle che Zhuangzi chiamava “trappole per pesci”. Dimenticare il linguaggio, quindi. Anch'io divento fantasma: muoio un po' dalla realtà per vederla meglio. Diceva Laozi: quando incontrerò qualcuno che abbia dimenticato il linguaggio per poter fare quattro chiacchiere con lui?
E poi c'è ancora l'esclusione e l'appartenenza della protagonista ad un mondo extra-ordinario. Come fosse un'anomalia lei stessa. Cosa ti affascina in questo?
Ho sempre riflettuto sull'estraneità, su cos'è veramente umano. Nell'altro libro l'estraneità era creata dal dolore, e Camelia era un'eroina tragica che lottava contro tutto e tutti, qui invece l'estraneità è connessa alla perdita dei confini, del sé e del corpo, e Dorotea è una ragazza che attraversa il mondo fin dentro il suo nocciolo. E' un essere che passa continuamente da una materia all'altra: da bambina, percepisce la propria crescita in parallelo al deterioramento della stanza in cui vive, senza stacco apparente; poi sua madre la fotografa con lunghi tempi di esposizione così nelle foto il suo corpo fluisce nella parete, non si distingue da essa. Da morta, il suo corpo è privo di materia quindi passa da una materia all'altra. Anche sul sé accade la stessa cosa (“Ma io non sono più io: in età postuma si perdono certe limitazioni. Io, o il mondo, continua come prima” la cito) Mi sono specializzata in buddhismo e mi sta molto a cuore la riflessione su cosa sia davvero l'io, sull'illusione dell'identità.”
Le immagini in questo libro restano sempre piuttosto tenebrose, nella faccia nera della medaglia. Il mondo non salvabile. Il dolore inevitabile. Come nasce questa costellazione di sensazioni?
Oh no, il mondo è salvabile, i miei personaggi aspettano pieni di speranza la resurrezione dei corpi: «Svegliatevi ed esultate o voi che abitate nella polvere! Poiché la tua rugiada è come la rugiada di una luce sfavillante e la terra darà alla luce i morti. Isaia 26, 19».”
E quali sono quelle inattese che ti fatto vivere il romanzo?
A tratti mi accecava: è un romanzo pieno di luce che si accende all'improvviso nel buio. Per reggere agilmente questi sbalzi dovevo essere sia gatto che girasole che vampiro. Ho anche pianto molto per Dorotea, e l'ho amata profondamente.
Le tenebre sono sempre l'altra faccia della luce. Ci dai una definizione di amore?
Questo è un romanzo pieno di amore. E' un amore sfasato ma sempre fortissimo. Il sesso è sempre voyeuristico, mai intimo, e non ci sono confini: né del corpo, che sprofonda fino alle ossa (fantasmi che s'inabissano) né emotivi. Dorotea ama tantissimo sua madre ma crede di essere la sua malattia. Ama Lorenzo, entomologo, e quando lei morirà gli insetti prenderanno possesso del suo corpo. Amore autarchico, un regno a sé, non interessato alle conferme: Dorotea-fantasma ama Alberto-vivo ma non sente un vero bisogno di essere riamata. Soprattutto c'è tanto amore per la vita. Un amore feroce (in cinese l'ideogramma di amore ha gli artigli). C'è l'amore per il proprio corpo: pazientemente, i morti, aspettano la resurrezione, e Dorotea, giorno dopo giorno, scrive sul diario del suo disfacimento sottoterra.”
Una colonna sonora per leggerlo?
Io ascoltavo la Moldava di Smetana, i Requiem di Mozart e Diamanda Galas.”
Come hai iniziato a scrivere la prima volta? E cos'è stata per te la scrittura? Da piccolissima non facevo altro che raccontare storie. Mio padre mi registrava. Poi a cinque anni ho cominciato a scriverle e non ho più smesso. L'ho sempre presa come una missione, come un imperativo biologico più forte del nutrirmi: da bambina, a un certo punto, insoddisfatta dalla vita reale e decisa a dedicarmi interamente alla scrittura, ho scritto e firmato un patto con me stessa in cui mi impegnavo a non parlare più con la gente e scrivere soltanto fino a quando avrei compiuto diciassette anni. Naturalmente poi non l'ho rispettato...
Ci sono letture che ti hanno influenzato?
I filosofi taoisti e la diaristica giapponese dell'anno mille. Storia di Genji di Murasaki Shikibu. In genere mi sento molto vicina all'estetica buddhista giapponese del “mono no aware”, la “tristezza delle cose”, che ha plasmato la letteratura di quegli anni: la contemplazione della bellezza che è prossima alla fine e dalla sua fine trae la ragione della sua bellezza. Poi ricordo il malessere fisico quando ho finito di leggere Mrs Dalloway, il mio libro preferito in assoluto. I più grandi romanzi sono letali.
Il tuo primo libro è stato tradotto in tutto il mondo. Il successo lo immaginavi cosi?
Credo che una volta tanto la realtà abbia superato la mia immaginazione!
E il tuo futuro come lo immagini?
Come ha scritto Philip Dick, non vedere il futuro è il miglior privilegio concesso all'essere umano. Io estendo il privilegio al non immaginarlo nemmeno. Tutto quello che immagino non riguarda me, non fino in fondo.
- Home
- Recensioni
- Viola di Grado torna in libreria con un viaggio nell'aldilà