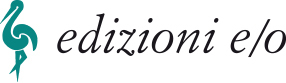Morte a Catania
Autore: Salvatore Ferlita
Testata: La Repubblica / Palermo
Data: 17 febbraio 2013
Viviamo in un'epoca letteraria di grandi esordi annunciati, di opere prime eclatanti quasi per definizione (i nomi da fare sarebbero troppi). Cominciare, in questo senso, vuol dire uscire con coraggio dall'ordine, tuffarsi vertiginosamente in un mondo che non si conosce per esperienza diretta, ma solo per sentito dire. Si è da soli a varcare questa soglia, trattenendo a stento il respiro. Ecco, in sintesi, la retorica dell'esordio quale oggi sempre più imperversa. A fare da velenoso controcanto, le parole che una volta scrisse Italo Calvino proprio a proposito dell'opera prima: «Dirò questo: il primo libro sarebbe meglio non averlo mai scritto. Finché il primo libro non è scritto, si possiede quella libertà di cominciare che si può usare una sola volta nella vita, il primo libro già ti definisce mentre tu in realtà sei ancora lontano dall'esser definito; e questa definizione poi dovrai portartela dietro per la vita, cercando di darne conferma o approfondimento o correzione o smentita, ma mai più riuscendo a prescinderne». Esordio, dunque, quale palla al piede, zavorra ad ogni costo. Veniamo a noi: forte di un'opera prima portentosa, quel Settanta acrilico trenta lana (edizioni e/o) che due anni fa le valse il Premio Campiello e l'assedio delle pagine culturali di non pochi quotidiani e spazi del web (a oggi tradotta in otto lingue), la giovane catanese Viola Di Grado si ripresenta con la sua nuova opera, Cuore cavo(e/o), annunciato già quale secondo capolavoro: «In un romanzo coraggioso e sorretto da una scrittura formidabile per originalità e poesia — recita la quarta di copertina — Viola Di Grado racconta la storia di un suicidio e di ciò che lo segue». Giochiamo subito a carte scoperte: Cuore cavo conferma a pieno titolo le doti di questa autrice così poco isolana per immaginario, pur non garantendo la stessa tenuta, quell'effetto d'insieme così convincente nel primo romanzo. Si diceva dell'immaginario poco siciliano dell'autrice, divaricato rispetto alle temperature ribollenti ai soliti fondali esotici per i quali spesso i nostri scrittori pagano uno scotto indecente. Tra gli scrittori siciliani delle ultime generazioni, Viola Di Grado è certamente la più nordica: apolide per formazione, studiosa di lingue orientali, questa scrittrice catanese che s'è nutrita di Leopardi sino quasi a intossicarsi, è riuscita a inserirsi nel grande filone del nichilismo cosmico. Verrebbe quasi da pensare che sia venuta fuori da una delle Operette morali dell'autore de La ginestra: a tal punto da imparentarla con quell'"islandese" insofferente e infelice del famoso dialogo, costretto a stare vicino al fuoco per le condizioni proibitive del clima. Narratrice boreale e artica, an- cora una volta la Di Grado parte dallo stesso grumo di dolore: un rapporto madre figlia così complesso e compromettente da trasformarsi in tritolo d'inchiostro, all'ombra di un'assenza misteriosa e lacerante: quella del padre. A dare la stura a questo secondo romanzo, il suicidio di chi dice io: una mossa alla Guido Morselli di Dissipatio h. g. viene da dire: solo che qui, il tentativo di mettere una pietra sopra alla vita va immediatamente in porto, offrendo un abbrivio ossimorico alla storia, in quanto la decisione di farla finita si tramuta in potente, irresistibile atto demiurgico. Dorotea Giglio, a venticinque anni, una sera di luglio riempie la vasca da bagno, si immerge e col rasoio incide diverse volte i suoi polsi sino a svuotarne le vene. Nel momento in cui decide di accomiatarsi dalla vita, inizia il suo sfibrante monologo, il suo delirio febbrile: la cronaca turbata (a cavallo tra il Dostoevskij delle Memorie del sottosuolo e il Celine di Viaggio al termine della notte) della diffusione geografica inarrestabile del rigor mortis. «Neanche la Bella Addormentata — si legge quasi all'inizio — sa quanto è breve il passo dal sonno continuo a quello eterno». Viola Di Grado, quale impavida trapezista, si spinge a narrare non solo quello che accade nel trapasso tra la vita e la morte, ma anche a disegnare la topografia di questo misterioso e sempre più algido altrove. Si assiste all'inizio a una sorta di deflagrazione, di propulsione atomica, uno sperpero di energia che si consuma e il suo conseguente assorbimento. Non finisce tutto con quel gesto: Dorotea si trova a vagare in una circoscrizione che non è né del tutto terra, né pienamente aldilà: vive senza occupare gli spazi, vede senza essere vista, ad eccezione del suo ex datore di lavoro (che di lei si accorge pure in soluzione incorporea), e soprattutto di Alberto, di cui si innamora perdutamente. Vorrebbe interagire, Dorotea, ma le manca il tatto; vorrebbe bramare ma le difetta il desiderio. Anche in questo caso, si snocciola un lessico famigliare fatto di censure, silenzi, effrazioni, una volutamente sgraziata koinè segnata da ferite e mancanze, modulata con estremo rigore dall'inizio alla fine. Si alternano lacerti di passato, al setaccio di una sensibilità sempre spiazzante, e schegge di presente: il reticolo di rapporti tra la madre e la figlia, quest'ultima e le zie (una di queste, Lidia, morta forse incidentalmente nel corso di una gita), si fa una gabbia asfissiante, dalla quale prova a venire fuori chi dice io. Ne deriva una funeraria odissea claustrofobica, un'ipnotica e visionaria danza della morte, in una Catania straordinariamente atrabiliare; che, però, ci avrebbe guadagnato non poco, qualora fosse stata sfrondata da certi sconfinamenti cimiteriali al limite del pulp e dello splatter.