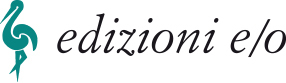Laurence Cossé, autrice nota in Francia, sembra voler dire – con questa storia – che senza la lingua, parlata e scritta, non si esiste, ed infatti Fadila chiude la sua vita nel silenzio, in coma, nella “immobilità di una figura sepolcrale” e a Édith, che la guarda, viene solo in mente che non è riuscita “a farle capire come combinare le lettere scritte in modo da formare parole mentalmente leggibili”, perciò non sarebbe possibile tentare di stabilire una qualche comunicazione in quello stato neanche con lo sbattere delle palpebre a seconda delle lettere. Ma io vorrei tentare un’altra lettura, considerando che leggere implica viaggiare, affrontando i piaceri ed i pericoli dell’ignoto (Derrida), sentendosi straniere in casa propria.
La storia mi suggerisce così l’impossibilità dell’incontro con l’Altra, che rimane lontana nella sua alterità, perché Édith – nonostante lo slancio di voler alfabetizzare Fadila per permetterle di compilare un modulo e leggere i nomi delle stazioni della metropolitana – resta prigioniera dei suoi privilegi, della sua vita agiata senza problemi, della sua raffinata cultura da traduttrice: non riesce infatti ad incontrarsi con la domestica immigrata, analfabeta anche in arabo, con una vita di violenze e difficoltà di genere alle spalle nel suo paese, ed un presente di emarginazione e fatica, una donna che appare recalcitrante alle sue lezioni, scostante talvolta, arroccata fra pregiudizi e tradizioni. È anche per questo, credo, che non riesce a trasmetterle l’alfabeto francese.
Nei racconti di Christiana de Caldas Brito le giovani donne arrivate dai paesi latino-americani, sradicate dal loro guscio familiare e dalla loro lingua, spesso si rinchiudono nel silenzio prima di ricorrere al ‘portuliano’, un miscuglio di portoghese ed italiano, che riecheggia il lessico degli emigrati italiani in Brasile nell’800/900. La parola nel corso dell’emigrazione, che è insieme “spostamento del corpo e dell’anima” (Djebar), ha spesso bisogno infatti di un periodo per poter emergere, e nelle prime donne arrivate si registra come un “silenzio fra due lingue”: per Dounia analfabeta che parla solo arabo e vive in Canada chiusa nello spazio domestico – protagonista de La felicità scivola tra le dita di Abla Farhoud (2001) – le parole sono i “rametti del prezzemolo” che lava, i peperoni che farcisce, le foglie di vite e di cavolo che arrotola per i suoi cari. Fadila non ha la fortuna di avere figli affettuosi che, grati del suo lavoro, le chiedono di raccontarsi, nutrendosi di quella invisibilità, ma, pur non scolarizzata, ha avuto il coraggio di emigrare e nel nuovo paese – dove esiste solo per eccesso (Sayad) – escogita sue strategie nel muoversi fra autobus e metropolitana, aiuta la famiglia, ha affetti, con una consapevolezza di esistere, che Édith forse non riesce a vedere. Quando il mondo in cui si è sradicati appare contrassegnato dall’inconoscibilità e il linguaggio dell’altra non corrisponde al linguaggio interiorizzato nell’attribuire significato a sé e al mondo, si rivela un divario doloroso, che Édith sembra non avere l’umiltà di capire nella sua ossessione di insegnare il francese, così preoccupata dalle lezioni – che del resto occupano pagine e pagine del romanzo – senza avere alcun dubbio esistenziale o politico di fronte alle emozioni ed ai problemi della domestica.
Fadila («ospite estranea, uguale a noi», dice Christa Wolf per Medea) usa parole spezzate, scorrette, storpiate ma comunque associate a persone, fatti, colori e sapori, odori e suoni, con una loro storia: affondano nella memoria e nel presente, negli scambi e negli incontri, nei vari mondi che ha attraversato, un’area semantica e affettiva, spaziale e emotiva legata al complesso retroscena culturale che ogni lingua si porta con sé, e che, contaminandosi, persiste in quello sfruttamento della povertà che Fitoussi chiama lo scandalo etico del capitalismo contemporaneo.
- Home
- Recensioni
- Un silenzio tra due lingue