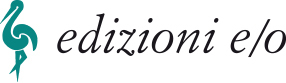Viola Di Grado ha esordito con un romanzo, Settanta acrilico trenta lana, che ha ricevuto elogi un po' dappertutto. Niente di strano, se si considera che chi scrive sui giornali tende a scoprire e lanciare geni a getto continuo, ma in questo caso sorprendono la giovane età dell'autrice, appena ventitreenne - il libro, per di più, è stato scritto due anni fa -, e una scrittura che poco concede ai giovanilismi e rivela invece una certa maturità. Non sembra, a dire il vero, nemmeno un libro italiano, bensì uno strano ibrido di letteratura orientale - cinese o giapponese - e anglosassone. A creare questo effetto contribuiscono sia l'ambientazione, una Leeds perennemente fredda e buia in cui l'unica stagione sembra essere l'inverno, sia un linguaggio denso di metafore e similitudini poeticamente insolite che però paiono disseminate nel racconto quasi con secca indifferenza o con aria di spregio. Non è neanche esatto dire che la scrittura di Viola di Grado non è enfatica, perché invece spesso lo è, ma di un'enfasi prosciugata e concentrata nelle sue componenti essenziali. Non di rado il lettore resta scosso dagli accostamenti arditi e dalle frizioni produttive tra elementi che, a prima vista, non dovrebbero avere nulla a che fare tra di loro e che, facendo scintille, aprono nuovi squarci di significato o illuminano di luce inedita quelli vecchi. Allo stesso tempo, però, è una scrittura molto sensuale e "materica": a leggere le pagine di Di Grado sembra di avvertire addosso quell'alito freddo che spira a Leeds e quel silenzio in cui è immersa la casa delle protagoniste.
Vale la pena fornire qualche esempio, pescato più o meno casualmente dalle pagine del romanzo: "Leeds è come quei padroni che sventolano sadicamente un pezzo di carne davanti al cane e poi se lo mangiano, quando esci vedi quel sole appeso al cielo e diventi più felice", "Lei era lì che mi squadrava come una principessa rancorosa punita dalla fata cattiva con cento anni di bruttezza", "Camminavo seguendo un tramonto lungo, spalmato sulla strada intera come ketchup", "Una domenica, quand'ero piccola, me lo ricordo, successe dicembre. All'improvviso. O almeno abbastanza dicembre da odiare le cose dell'universo", "Si chiama vita il gioco che fanno tutti gli esseri umani senza di me", "Mi ero suicidata al contrario, buttandomi sulla vita senza paracadute", "Torno a fare la guardia del corpo della mia tristezza", "Ormai la bellezza se solo la pronunci scende la pioggia a disinfettarti la bocca", "Fuori era talmente aprile che dovevo schermarmi gli occhi con la mano, troppa luce, così tanta che non ci credi che Dio a farla ci ha messo solo un giorno", "Mi faceva male tutto quello che in un corpo umano è capace di produrre dolore. Avevo freddo fin dentro la memoria. Tutti i miei ricordi avevano le labbra viola"... Ci sono poi un paio di pagine magistrali, caratterizzate da un espressionismo intenso ma misurato, in cui l'autrice riesce a rendere con plastica perfezione lo stato d'animo della protagonista e il suo senso di isolamento dal resto del mondo in cui tutti, per il semplice fatto di vivere, amare e spassarsela, sembrano irridere la sua infelicità, accrescendo così il suo sentimento di inappartenenza.
La trama, in sé, è piuttosto semplice e racconta, in prima persona, la storia di Camelia Mega, giovane torinese trasferitasi da bambina a Leeds con la mamma musicista e il papà giornalista. Dopo la morte del padre - e la scoperta di una sua relazione extraconiugale con una collega - la ragazza abbandona gli studi di cinese all'università e si ritrae in un guscio di dolore in cui tutti gli oggetti lasciati dal padre non sono soltanto testimoni muti della sua sofferenza, ma irradiano a loro volta dolore. Compulsivamente Camelia raccoglie vestiti scartati nei cassonetti e li modifica tagliuzzandoli e mutilandoli: è il suo per sfregiare la bellezza del mondo che ostinatamente continua a manifestarsi assalendola all'improvviso. La madre Livia si rinchiude nel mutismo fino a comunicare con la figlia in una lingua elaborata fatta solo di sguardi e non abbandona più la casa di Christopher Road (e, detto per inciso, la geografia e la toponomastica sono precisissime, tanto che a tratti ho seguito i movimenti della protagonista attraverso Googlemaps, consultando anche le immagini dei luoghi citati nel romanzo, a partire proprio dagli edifici di Christopher Road). Tra le due si sviluppa un rapporto lievemente morboso, in un setting che è al tempo stesso claustrofobico e "claustrofilico". Un giorno Camelia incontra un ragazzo cinese, Wen, se ne innamora e grazie al suo aiuto riprende a studiare la sua lingua, immergendosi in un universo di ideogrammi che a poco a poco, con le loro "chiavi", si sovrappongono alla realtà fino a diventare una lente attraverso cui osservarla e uno strumento con cui rappresentarla simbolicamente. Però anche Wen ha i suoi lati oscuri, incluso un fratello, Jimmy, lievemente ritardato con cui la stessa Camelia instaurerà un rapporto complementare a quello che ha con Wen. Il finale del romanzo non è affatto ovvio e prevedibile, coglie anzi il lettore un po' di sorpresa e non lo rivelerò per non rovinare il gusto della scoperta a chi fosse interessato a leggerlo.
Ci sono sicuramente delle ingenuità in questa opera prima di Viola Di Grado - e per fortuna, mi verrebbe da aggiungere -: certi giochi di parole un po' forzati e innaturali o un uso di "fottuto" (e "fottutamente") a volte un po' insistito, che fa troppo "cinema americano", ma si tratta di sbavature minori. Certo è che Settanta acrilico trenta lana resta un romanzo inusuale e affascinante e Viola Di Grado si rivela una bella promessa delle lettere italiane. Rimane da vedere se la promessa verrà mantenuta o se si sgonfierà perché qui c'è tutto quello che l'autrice aveva da dire: la aspettiamo al varco della sua prossima opera.
- Home
- Recensioni
- Settanta acrilico, trenta lana: un esordio