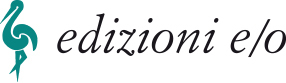Di lei avevo sentito parlare, alla televisione, alla radio, su internet, insomma dappertutto. Lei è Viola Di Grado, autrice del libro Settanta acrilico trenta lana, scritto dall’esordiente scrittrice all’età di ventuno anni. Forse tutto questo parlane a profusione è stata la causa per cui lo avevo semplicemente ignorato, il libro, un po’ come quando siamo saturati da troppe informazioni fino a diventarne indifferenti. Poi qualche pomeriggio fa, in giro per gli scaffali della Feltrinelli, mi è capitato per caso (furbi librai!) per le mani e l’ho acquistato senza rifletterci troppo. Ok, veniamo al punto: Settanta acrilico trenta lana (Edizioni E/O) è stato per me una vera rivelazione (in realtà il fatto che si fosse aggiudicato il Premio Campiello Opera Prima dice già qualcosa). Una rivelazione tale da non dormire un’intera notte pur di andare avanti con le pagine!
Una scrittura simile al delirio, un trabocco di parole una dopo l’altra, quasi senza prendere mai fiato, ma con una padronanza linguista straordinaria, al di fuori di ogni rigore letterario. Una flotta di parole, quelle dette e quelle non dette che viaggiano sotto forma di sguardi. Sì perché Camelia Mega, la protagonista del romanzo, sviluppa con la madre Livia, che si rifiuta di parlare, un codice linguistico fatto di sguardi, ognuno con un preciso significato che solo loro possono capire. Entrambe segnate dalla morte del padre (per Camelia) e marito (per Livia) si rinchiudono in una non-storia immune da parole, fatti e persone. A questo si aggiungono altri fattori che s’intrometteranno nella non-storia di Camelia tessendo infine una trama e irrompendo nel suo isolamento.
Uno è Leeds – dove Camelia vive con la madre dopo essersi trasferita dall’Italia a causa del lavoro del padre – cittadina inglese segnata esclusivamente da un inverno senza sosta, da cieli grigi e dal degrado del quartiere che ben si sposa con la reclusione delle due donne.
Un altro è Wen che riporta le parole nel mondo di Camelia veicolate da ideogrammi cinesi e dalle loro chiavi, ma che non riesce a soddisfare come lei vorrebbe il suo bisogno di essere amata. E poi c’è Jimmy, lo strano fratello di Wen e gli abiti nel cassonetto che Camelia recupera per poi mutilarli e ricucirli in assurde combinazioni.
E poi c’è di nuovo Livia, la madre, ex flautista che rinchiusa nel suo isolamento verbale, e non solo, abdica il suo ruolo di madre alla figlia, mortificando inoltre la bellezza che la contraddistingueva. L’unica ossessione di Viola sono i buchi che non riesce a smettere di fotografare di continuo.
Infine, ma non per ultimi, ci sono i testi di un manuale per lavatrici che Camelia traduce dall’inglese all’italiano e le cui frasi seguono la trama della storia e che diventano metafore della vita stessa.
Camelia non è un personaggio costruito sull’auto-commiserazione, ma affronta ciò che le capita – dalla morte del padre alla depressione della madre – con rabbia ribellandosi a quella stessa vita e quel mondo che continuano a buttarla fuori dalla sua stessa storia.
- Home
- Recensioni
- IL LIBRO DEL MESE: “SETTANTA ACRILICO TRENTA LANA” DI VIOLA DI GRADO