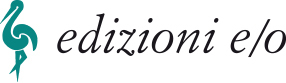È un piacere ospitare nel salotto virtuale di @CasaLettori la giornalista e scrittrice Stefania Nardini.
Mi piace immaginare che la nostra conversazione si svolga a Marsiglia, luogo di incontro e di condivisione, città molto presente nello splendido romanzo “La combattente”, pubblicato da Edizioni e/o.
Un libro che si ama fin dalle prime pagine non solo per la qualità della scrittura.
È un viaggio nel tempo, una storia d’amore, un atto di ribellione.
Come è nato “La combattente”?
Da un’esperienza personale. La perdita di mio marito dopo 30 anni di vita insieme, mesi trascorsi nella nostra casa in campagna a tentare di capire come fosse possibile una rinascita.
Il suo romanzo affronta con coraggio un periodo storico che volutamente è stato dimenticato.
Cosa ha significato ripercorrere gli anni di piombo?
Per me è stato “naturale”. Nell’aprire una lunga riflessione sulla mia vita e sulla mia storia non potevo evitare l’analisi di un’epoca che ha influito sulle scelte di una generazione come la mia.
Perché i ricordi della mia gioventù sono là.
I ricordi di una generazione sono là.
E non si può affrontare un tema personale privandolo di una contestualizzazione.
E per farlo è stato indispensabile lo strumento letterario che mi ha consentito di spaziare nella costruzione del racconto.
Un’operazione naturale e liberatoria.
Visto che di quegli “anni” non c’è una narrazione storica.
E l’etichetta del “piombo” , che innegabilmente c’è stato, è riduttiva, li liquida come zona del male, foraggiando il sentimento ormai fin troppo diffuso dell’anti politica, o della politica ridotta allo spettacolo che è sotto in nostri occhi.
Nella ricostruzione degli eventi emerge un raffinato lavoro di ricerca.
Quanto influisce nella sua scrittura l’approccio giornalistico?
Devo dire che se in altri miei lavori la ricerca storica ha costituito la base dei miei lavori, in questo caso la ricerca è stata prevalentemente nella mia memoria.
Nelle letture che mi hanno appassionato negli anni, in quel mio essere spesso fuori dal coro, nel non aver mai abbandonato la memoria della mia formazione.
Che è stata anche quella giornalistica, quando il giornalismo era il culto della verità.
Quando il giornalismo aveva una responsabilità civile.
Angelita può essere considerata icona di un presente che vuole sconfiggere l’oblio?
Angelita è il presente.
Un presente di cui nessuno parla, che per usare un termine alla moda viene considerato di nicchia, ma che nicchia non è.
Lo dimostra l’interesse per il romanzo non solo da parte del lettore mio coetaneo ma anche da parte di chi non ha ricevuto un’eredità storica.
Angelita è il presente di donne sole che scrivono sui social i loro pensieri, oltre i quali c’è molto di più di una frase ad effetto.
Perché il presente di Angelita è intriso di un passato che le offre gli strumenti per guardare al futuro. Perché è il passato che ci suggerisce “si può fare” “ce la possiamo fare” , è “accaduto che ce l’abbiamo fatta”.
Forse per questo gli anni 70 sono un tabù.
Sono anni scomodi nell’arena dei likes.
Sono anni in cui le persone non si arrendevano facilmente, al di là degli errori.
E Angelita si serve della sua storia per farcela.
Uno dei compiti della letteratura è far emergere la verità, anche quando è scomoda.
Quanto è doloroso scavare tra le macerie del passato?
Non so se è doloroso.
Potrebbe essere liberatorio.
E’ indispensabile sporcarsi le mani con le macerie per costruire il nuovo.
Il suo libro ha il pregio di essere giudice implacabile di una generazione.
Cosa è rimasto di quei sogni?
Più che giudice, un testimone.
Di quei sogni c’è molto.
Intanto molti di quei sogni sono realtà e questo non dovremmo dimenticarlo.
E dovremmo sentire il dovere di difendere le tante conquiste di civiltà prodotte da quella storia. Nonostante l’attentato continuo che punta a fare a pezzi quelli che ci sono stati riconosciuti come i pilastri di una società democratica.
Quei sogni, che erano grandi sogni, hanno contaminato le coscienze sia pure nell’inconsapevolezza. Mentre è indispensabile ritrovare una nuova consapevolezza per rimpossessarci dell’idea di essere soggetti sociali, protagonisti di una politica che nessuno ci impedisce di rielaborare, di costruire. Siamo tutti liberi di farlo.
La figura di Fabrizio è metaforica rappresentazione di un dolore insopportabile.
Il suo approccio psicologico vuole mettere in luce le fragilità?
La fragilità è propria dell’essere umano.
E con le nostre fragilità ci troviamo a fare i conti.
E credo vadano accettate per quello che sono.
Fanno parte di noi e dobbiamo amarle nella loro autenticità.
Perché non riconoscerle?
In nome di cosa?
Di un cliché che deve far fede alla nostra esteriorità?
Quanto la sua Marsiglia è simile a quella di Izzo?
Marsiglia è Marsiglia.
Izzo è Marsiglia.
E chi si avvicina a Marsiglia non può farlo con superficialità.
E’ una città complessa, in continua evoluzione.
E la “mia” Marsiglia è quella che vivo, che amo e odio, e poi amo ancora.
E’ un sentimento che accomuna molti marsigliesi di adozione, come nel mio caso, e non.
Izzo l’ha resa reale nella sua emozionalità, come un sentimento.
Perché Marsiglia è un patto d’amore.
Il messaggio che ha voluto lanciare?
Rinascere è possibile.
Sempre.
Rimuovere è il primo passo per costruire un alibi.
Nella trama si percepisce un bisogno di rappresentare il tempo.
La sua vuole essere una lettura filosofica?
Più che filosofica di riflessione.
Programmi futuri?
Non ne ho idea.
Spero di continuare a scrivere.
Quando sentirò di avere qualcosa da dire.