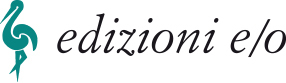A prenderla larga si potrebbe arrivare sino all’Antigone, al dissidio tra legge divina e legge sovrana. Anche se di divino c’è più quasi niente, sicuramente non nella legge. E allora, dato che il genere impone brevità, intuito, idee sì, ma soprattutto rapidità di azione, l’antica Grecia la si può lasciare da parte. E fregarsene anche della legge, quando si discosta dalla giustizia, e pure della giustizia quando non è poi così giusta. Il noir è terreno dove le ombre superano le luci, che scorrazza in territori foschi, entro i quali i perimetri sono incerti, i connotati si confondono e non è sempre facile orientarsi. Anche, e forse soprattutto, tra quello che è lecito, quello che non lo è. Tra chi sta da una parte e chi dall’altra di quella grande bugia che è il crinale tra il bene e il male.
Non ci sono ispettori o commissari o vicequestori, la polizia non risolve niente, al massimo nasconde. Le indagini non sono avallate da un giudice e molte volte la giustizia è sommaria, centra niente con la legge. L’Alligatore è uno che non potrebbe fare quello che fa, ma lo fa lo stesso. L’Alligatore è Marco Buratti, per nome e cognome, è Massimo Carlotto per discendenza letteraria. È investigatore privato ma senza licenza, per professione, detective fuori norma, in ogni caso periferia della legge. Quella che l’ha sbattuto in carcere da innocente, quella che molte volte non è del tutto linda. L’Alligatore si muove tra le ombre del padovano, in quel Veneto di piccole vetrine e immensi retrobottega, che lo scrittore Luigi Meneghello descrisse come “una regione dove le contraddizioni continuano ad autogenerarsi in un flusso costante di opacità e splendore”. Il Veneto di Massimo Carlotto, sincero e spietato, ma mai macchiettistico. Un’epifania che lascia nel lettore la consapevolezza di ritrovarsi all’interno di quella “cartina al tornasole dell’Italia, nella quale la ricchezza, la bellezza, lo specchiarsi della realtà viaggiano su un’autostrada che non sempre intercetta le strade comuni”, scriveva Goffredo Parise.
L’Alligatore era tratteggiato nero su bianco nelle righe di una lunga serie di romanzi, al massimo in toni di grigi, di blu e di violetti nelle tavole di Igort sceneggiate dallo scrittore in “Dimmi che non vuoi morire”. È stato così per venticinque anni. Lì l’Alligatore è diventato maggiorenne, ha superato l’adolescenza, è entrato nella maturità, almeno per quanto riguarda la sua vita da personaggio letterario. Ora è diventato anche immagini in movimento, pixel, serie tv diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, che questa sera debutta su RaiDue (su RaiPlay c'è già da qualche giorno). Ha assunto una fisionomia, quella di Matteo Martari, non più fatta di parole e aggettivi, slegata per la prima volta dalla nostra immaginazione, dalla nostra elaborazione delle righe di Massimo Carlotto. È diventato voce. Musica non più solo canticchiata tra le pagine. Non poteva andare altrimenti, di musica è fatto il noir.
Osvaldo Soriano scrisse che il noir “è come il jazz, è libero, reinterpreta la società, le sue leggi. È bebop, veloce e ribelle come Dizzy Gillespie”. Per David Bowie il noir era invece punk, “contrario alle regole, distruttivo, ma non nel senso estremo. Come il punk distrugge per ripianare e ripartire”.
L’Alligatore però non è né jazz né punk, è blues. Quello che ascolta, quello di cui nutre la sua anima e nel quel quale si riflette. Quello che era origine di tutto e filo rosso di ogni vicenda. Perché “prima di finire nei guai ero il cantante di un gruppo, gli Old Red Alligators, e fu così che iniziarono a chiamarmi Alligatore. (…) Dalla galera sono uscito senza più la voglia di cantare e suonare. Mi va solo di ascoltare. E di continuare a bere. Ormai soltanto il calvados, tutto ciò che mi rimane di una donna perduta in Francia. Un tempo tutto quel che mi capitava a tiro, perché “puoi togliere il blues dall’alcol ma non l’alcol dal blues”. O così almeno così Massimo Carlotto fa presentare il suo personaggio in “La verità dell’Alligatore”.
La serie tv dell’Alligatore di blues ne ha e di buono, scelto e musicato da Teho Teardo (con l'autore). Parte però con uno schiaffo, un pugno in faccia, qualcosa che non quadra. Troppo bello Marco Buratti, troppo magro Max La Memoria, troppo giovane Beniamino Rossini. Troppo e basta.
Come un blues l’avvio può essere un inganno. E come certi blues, buoni blues, ci mette un po’ a prendere corda, ritmo. Ma lo prende. A patto di non fissarsi sui dettagli da lettore, capire che è fiction, non letteratura, un altro prodotto, un’altra dimensione dell’Alligatore.
E venticinque anni e dieci libri dopo, va bene così. Pure all’Alligatore deve essere concessa una seconda vita. Che poi è la terza, o forse la quarta. Cin cin.